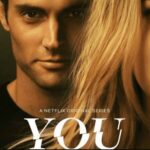Bob Dylan spiega la ‘Filosofia della canzone moderna’

Nel suo terzo libro, uscito in Italia l'8 novembre, Bob Dylan, Nobel per la letteratura, analizza 66 canzoni in una sorta di poema epico sulla natura della popular music e sulla condizione umana. A raccontarlo un lungo servizio pubblicato sulla rivista musicale Rolling Stones US.
Quanta nostalgia di un modo di far musica che sta morendo.
Chronicles Volume 1 non era neanche lontanamente un’autobiografia nell’accezione tradizionale del termine. Non lo era per il modo in cui Bob Dylan evitava la narrazione cronologica e il racconto delle storie che stanno dietro ai suoi dischi più amati. Per non parlare della prosa da far girare la testa di Tarantula, il suo romanzo sperimentale degli anni ’60. In confronto a questi due, il suo terzo libro Filosofia della canzone moderna (uscirà l’8 novembre per Feltrinelli, titolo originale The Philosophy of Modern Song, ndr) parrebbe semplice: annunciata come «una lezione sull’arte e il mestiere di scrivere canzoni», è una raccolta di 66 saggi che Dylan dedica alle sue canzoni preferite.
Dylan non ha scritto alcuna prefazione o introduzione per spiegare il criterio di scelta dei pezzi, che spaziano dal country e blues fino al pop “middle of the road”, a London Calling e al classico di Cher Gypsies, Tramps and Thieves. Si potrebbe pensare che questi dischi siano per lui indispensabili e che il libro sia una sorta di estensione del programma radiofonico da fanatico della musica Theme Time Radio Hour. Trattandosi di Dylan nulla è semplice e difatti la sua Filosofia della canzone moderna riserva sorprese e momenti sconcertanti, né più né meno come gli altri suoi libri. In parte è una lezione sulla musica, in parte una filippica in stile podcast, ma imprevedibile, lunatica e affascinante. Proprio come Dylan.
Corredato da foto di negozi di dischi, fabbriche per la stampa del vinile, copertine, cartoline di Elvis e vari oggetti da collezione, il libro evoca un mondo lontano: quello dell’America dei supporti fisici e delle canzoni che l’accompagnavano. Nei panni del critico musicale, Dylan s’entusiasma per il fraseggio di Bobby Darin in Beyond the Sea, parla della solidità dell’arrangiamento in Your Cheatin’ Heart di Hank Williams e si trasforma nel commesso di Alta fedeltà lodando una ristampa dei Temptations in cui sono state eliminate le basi musicali così che si senta solo il loro canto celestiale (o, come scrive lui, «armonie vocali costruite con precisione che trattano dei problemi realissimi di quel momento storico»). Nelle sue occasionali playlist da nerd, si concentra su canzoni con titoli che includono i termini “money” (denaro) “fools” (sciocchi) e “shoes” (scarpe). E se mai vi siete chiesti quanti standard contengono il nome Ruby, lo scoprirete leggendeo queste pagine.
Alla luce di alcuni suoi dischi recenti quasi alla Frank Sinatra, è chiaro che Dylan ama i crooner. Si spertica in lodi per innocui specialisti in ballate anni ’50 come Perry Como («Decisamente incredibile») e Johnnie Ray, ma anche per interpreti solitamente relegati alle note a piè di pagina come Jimmy Wages, che con Elvis è cresciuto a Tupelo, Mississippi, senza però sfiorare neanche lontanamente il successo dell’amico.
In un capitolo dedicato a Viva Las Vegas di Elvis, Dylan difende il Colonnello Tom Parker, che ha sempre creduto nel suo cliente e gli è sempre stato fedele. Nella sua analisi di Poor Little Fool sostiene che Ricky Nelson, talento genuino dalle doti canore modeste, è stato un «vero ambasciatore del rock’n’roll», più di Elvis, e questo perché nella sitcom dedicata alla sua famiglia ha cantato pezzi rock’n’roll della prima ora.
Nei box che accompagnano alcuni di questi brani troviamo delle digressioni, come nel caso di Pump It Up di Elvis Costello che apre a Dylan la strada per riflettee su come i rocker inglesi spesso indossassero dei completi, mentre le loro controparti statunitensi «mettevano blue jeans e scarpe da lavoro». La gemma honky tonk di Wenn Pierce There Stands the Glass ci fa scoprire un aneddoto su Nudie Cohn e i suoi tipici vestiti da cowboy indossati da star del country come Gram Parsons. Volete sapere cosa pensa Dylan a proposito dei film in streaming da guardare con lo smartphone? Ne potrete leggere nel capitolo dedicato a My Generation degli Who. Scrivendo del pezzone bluegrass Ruby, Are You Mad degli Osborne Brothers, arriva a paragonare quel genere all’heavy metal, dicendo che «entrambi non sono cambiati nell’arco di decenni» e che «i fan di entrambi si vestono ancora come Bill Monroe e Ronnie James Dio» (quindi Dylan sa chi è Dio, chi l’avrebbe mai detto).
Fedele all’abitudine di Dylan di cambiare bruscamente direzione, il libro non è solamente un excursus sulle canzoni che ancora affascinano un ottantenne. Nei capitoli su Midnight Rider di Gregg Allman, Witchy Woman degli Eagles e Black Magic Woman di Peter Green, fra gli altri, regala dei poemi evocativi, a volte bizzarri, dedicati ai protagonisti dei brani. Non è molto plausibile che Don Henley e Bernie Leadon pensassero alla loro strega come a «un’anziana ranocchia che vede col naso e annusa con la lingua» e «si presenta con parrucca, occhi artificiali, gioielli e magliette di brand di cosmetici». Eppure è quel che fa Dylan e la sua scrittura, in questi passaggi, ricorda l’oscurità cavernosa della sua voce.
A volte tralascia del tutto i collegamenti musicali. Feels So Good, un inedito un po’ jump swing e un po’ rockabilly di Sonny Burgess, lo porta a mugugnare sullo stato attuale dell’America e sul periodo «prima che l’America venisse sedata fino a scivolare in un torpore che la fa a malapena funzionare. […] Se vi domandate come possa cadere una nazione, basta guardare gli spacciatori». Da provocatore a cui sta a cuore il tema delle pari opportunità, si aggancia alla canzone di protesta contro la guerra in Vietnam di Pete Seeger Waist Deep in the Big Muddy per brontolare sul tribalismo dei media moderni, deprecando sia «i piagnucolii della sinistra» che «gli slogan della destra». Per Dylan, le piattaforme che abbracciano una sola rigida opinione politica o culturale sono «l’equivalente di lasciare che un bambino di 8 anni scelga che cosa mangiare». Quel bambino «finirà malnutrito, con i denti cariati e obeso». Date subito a quest’uomo un podcast.
Filosofia della canzone moderna non è Chronicles Volume 2, ma in vari punti si rivelano frammenti del suo pensiero sulla vita moderna. Data la nota riservatezza sulla sua vita privata, è semplice intuire come interpreti Blue Suede Shoes di Carl Perkins come «un segnale indirizzato a intrusi, spioni e invadenti: andate a ficcare il naso altrove e fatevi gli affari vostri». A Certain Girl, l’ode alla privacy del 1961 firmata da Ernie K-Doe, secondo Dylan parla di qualcuno che «sa come si tiene un segreto» e non ti tradirà. E, per spiegare meglio il concetto, analizza brevemente anche Do You Want to Know a Secret dei Beatles.
Nel capitolo su Cheaper to Keep Her, il pezzo soul degli anni ’70 di Johnnie Taylor, Dylan dedica una pagina alla canzone e le quattro seguenti sono un sermone contro l’esosa industria dei divorzi, nelle grinfie della quale è stato trascinato almeno una volta nella sua vita. Ovviamente non offre dettagli personali, ma i suoi commenti caustici («lavorano, per definizione, nel business della distruzione: distruggono le famiglie») sono fra i più velenosi del libro: incolpa quel settore di causare «suicidi fra gli adolescenti e il manifestarsi di serial killer». In chiusura parla del «matrimonio poligamo» per «donne maltrattate senza futuro, sballottate dai capricci di una società crudele». Per evitare che le femministe gli diano «la caccia con le torce in mano», aggiunge che sarebbe giusto porre delle condizioni, ovvero una donna che guadagna bene potrebbe sposare più uomini di cui occuparsi. «Fate pure, signore», aggiunge, ben sapendo che tasto ha appena toccato. Lo pensa davvero o ci sta solo manipolando, come fa da decenni?
Per quanto certi collegamenti sembrino folli, Dylan in realtà coglie la magia e il fascino della musica. Può essere la melodia, il testo o l’arrangiamento, ma un vecchio disco che ami può spingerti a riflettere sul mondo o sulla tua vita, su come la musica sia cambiata nel bene o nel male. Nell’apparente follia di Dylan c’è una logica, anche quando arriva a trovare nel testo di The Pretender di Jackson Browne più significati di quanti l’autore stesso ha immaginato.
Con una sola eccezione (Dirty Life and Times di Warren Zevon, dall’album che il cantautore ha inciso nel 2003 poco prima di morire), tutti i pezzi di cui si occupa Dylan risalgono al Novecento. Non c’è traccia di hip hop contemporaneo, pop dei nostri giorni o rock’n’roll successivo agli anni ’70. Qualche indizio sulla motivazione di questa scelta ce lo dà. Nella sua ode alle armonie country anni ’50 di Poison Love (di Johnnie and Jack), si lamenta di come il rock da musica per «feccia coi giubbotti di pelle che facevano dischi rockabilly» sia diventato roba da «fibbie per cinture dei Kiss vendute nei centri commerciali e tatuaggi lavabili con scritto “Thug Life”». Your Cheatin’ Heart lo porta a recriminare su come nella musica contemporanea manchino «i chiaroscuri, le sfumature, il mistero». «Forse è il motivo per cui, al momento, la gente non affida più i propri sogni alla musica; i sogni soffocano in ambienti così, senza ossigeno», scrive in modalità “divinità adirata”. Per lui, le canzoni non hanno più sangue: forse qualcuno dovrebbe fargli ascoltare qualche disco di Julien Baker o Tyler, The Creator.
Si sa che la musica che ascoltiamo da teenager lascia solitamente un segno più profondo sulle nostre vite e Filosofia della canzone moderna dimostra in parte questa teoria, anche se alcuni dei pezzi Dylan li ha sentiti che aveva già una ventina d’anni e più. Le sue scelte sembrano sincere. Ma quanto sarebbe stato intrigante leggerlo a proposito della versione lunga di All Too Well di Taylor Swift (la Sad Eyed Lady of the Lowlands della sua generazione) o del panorama tetro e impregnato d’alcol di Swimming Pools (Drank) di Kendrick Lamar?
Il libro finisce per essere un omaggio al tempo in cui il fondamento della musica erano le forme popolari come il folk, il country, il blues, e non i beat, i trucchetti e le tecniche da studio. Filosofia della canzone moderna è la testimonianza definitiva sul modo in cui le canzoni venivano scritte, suonate, registrate e cantate. Dylan lascia il futuro e il piacere della contemporaneità a chi scriverà la propria versione di questo libro.