Chi guiderà i palestinesi dopo Hamas e Abu Mazen?
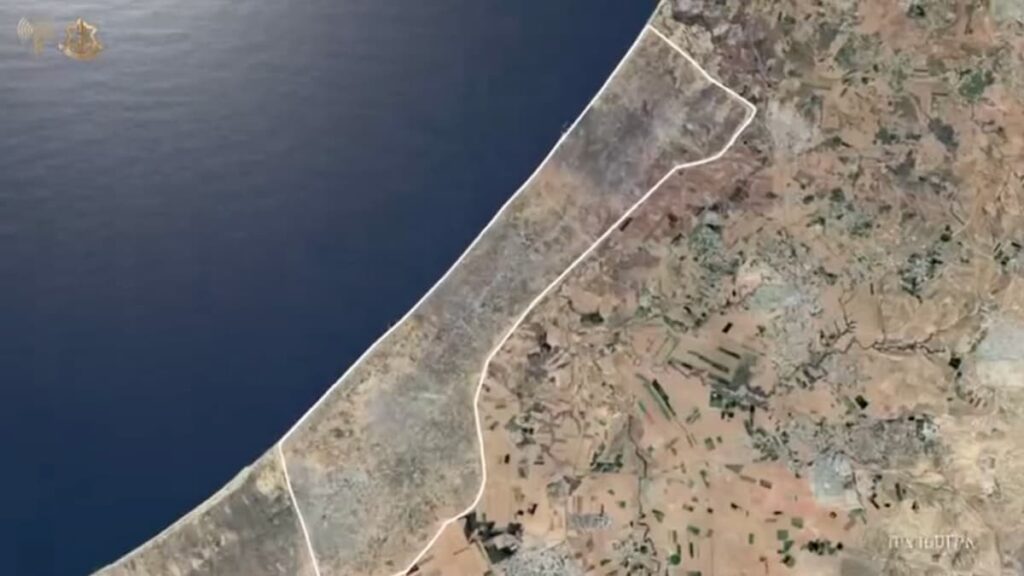
La politica internazionale ha spesso il vizio di ridurre la tragedia palestinese a una somma di slogan. Stato sì, Stato no. Due popoli, due Stati. Oppure: Israele vincitore, Hamas sconfitto. Eppure, dentro l’ennesima trattativa per un cessate il fuoco, emerge un dettaglio che dettaglio non è: il possibile rilascio di Marwan Barghuthi, leader di Fatah incarcerato dal 2002. Una figura che potrebbe riscrivere gli equilibri non solo palestinesi, ma mediorientali.
Barghuthi è il grande assente della scena politica palestinese. In carcere da oltre vent’anni, è rimasto un simbolo di resistenza, popolare persino tra chi non appartiene al suo schieramento. La sua scarcerazione, oggi messa sul tavolo come parte dello scambio ostaggi-prigionieri, significherebbe molto più della libertà di un uomo. Sarebbe un terremoto politico: indebolirebbe Abu Mazen, percepito come un presidente logoro e screditato; sfiderebbe Hamas, incapace di proporsi come interlocutore internazionale credibile; costringerebbe Israele a fare i conti con un interlocutore imprevisto, forse scomodo, ma radicato nella società palestinese.
E qui nasce il paradosso: Netanyahu, che a parole nega ogni legittimità allo Stato palestinese, potrebbe ritrovarsi ad aprire la porta al suo possibile futuro leader.
La domanda cruciale: quale modello di Stato?
Il vero nodo non è solo chi guiderà i palestinesi, ma che modello politico offrirà. Le alternative sono note e, tutte, problematiche: Ramallah ha mostrato il volto di una governance corrotta e inefficiente, incapace di conquistare la fiducia del popolo e Hamas ha imposto un regime di terrore, fondato sull’ideologia della morte e sulla violenza senza limiti.
L’opzione democratica, evocata dagli ottimisti, resta più un auspicio che una realtà: richiederebbe riforme profonde, una nuova cultura politica e la capacità di trasformare il conflitto in convivenza. Se davvero Barghuthi dovesse uscire di prigione, dovrebbe scegliere: ripetere i fallimenti del passato, o tentare la strada della legittimazione attraverso urne trasparenti e istituzioni solide.
Il destino palestinese non si gioca soltanto a Gaza o Ramallah. Accanto alla questione degli ostaggi, Trump ha evocato Arabia Saudita, Iran, Pakistan, Indonesia. Non solo perché musulmani, ma perché attori chiave del nuovo scacchiere geopolitico. Tutti, non a caso, legati ai Brics, il blocco che unisce Russia, Cina e le economie emergenti.
Mosca, per esempio, ha già dato il suo via libera al “piano Gaza”. Non per amore di pace, ma perché il Medio Oriente è un terreno in cui il Cremlino rivuole spazio e influenza, approfittando della stanchezza europea e dell’isolamento delle istituzioni multilaterali. In questo scenario, la Palestina diventa pedina di un ordine mondiale che si va ridefinendo: meno globalismo, più Stati-nazione, più logiche di potenza.
Si torna a un sistema antico: quello in cui i conflitti non li risolvevano le organizzazioni internazionali, ma le capitali, con accordi diretti e spesso brutali. Una logica che piace a Russia, Cina, Brasile e agli stessi Paesi islamici emergenti. Per loro, parlare di autodeterminazione palestinese significa, in realtà, rafforzare un modello di relazioni basato sui governi forti e sull’esclusione di organismi come ONU e UE.
Ed eccoci al punto più amaro. Il futuro dell’ordine mondiale — la definizione di un equilibrio che riguarda miliardi di persone — rischia di dipendere dalla resa o meno di un gruppo terrorista. Da Hamas, che dopo aver insanguinato Israele il 7 ottobre 2023, oggi ha nelle mani la possibilità di consegnare le armi e liberare i civili.
Che questa scelta gravi sulle spalle di milizie fanatiche è un’assurdità storica. Ma è anche il segno di quanto fragile e manipolato sia il destino di Gaza e, con esso, della Palestina.




