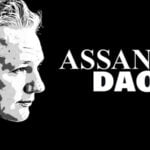L’assalto alle università americane: perché colpire l’élite accademica fa comodo al potere

L’assalto alle università americane: C’è un paradosso che attraversa gli Stati Uniti: le istituzioni accademiche più prestigiose del Paese – Harvard, Princeton, Columbia, Brown, Northwestern, Penn, Berkeley, NYU – vengono dipinte come una minaccia. Eppure sono proprio loro ad aver contribuito, più di ogni altra struttura, alla crescita culturale, scientifica ed economica americana. Perché allora diventano bersagli?
La risposta va cercata in una combinazione esplosiva di calcoli politici, visioni ideologiche e voglia di controllo.
Il movente profondo: riscrivere la cultura
Non si tratta solo di tagli ai finanziamenti. C’è qualcosa di più viscerale. L’attacco guidato da Trump e alimentato da figure come Peter Thiel nasce da un'idea radicale: le università sono diventate roccaforti di conformismo e censure mascherate da progresso.
Secondo questa visione, l’accademia d’élite sarebbe un mondo autoreferenziale, incapace di parlare al Paese reale, lontano dagli interessi della "gente comune". Un mondo da ridimensionare. O da ribaltare.
La miccia recente ha un nome preciso: le proteste nei campus dopo lo scoppio del conflitto in Medio Oriente. La risposta politica è stata fulminea. Accuse di antisemitismo, inchieste lampo, richieste di dimissioni. Ma è solo l’ultimo capitolo.
L’amministrazione Trump e l’universo conservatore hanno per anni denunciato una presunta discriminazione nei confronti delle voci di destra. Parlano di un ambiente ostile, dove chi non si allinea rischia l’emarginazione.
Il bersaglio non è solo il pensiero critico, ma la struttura stessa delle università. Il blocco dei fondi federali non è casuale: serve a piegare le istituzioni a un’agenda più ampia. L’obiettivo? Ridurre l’indipendenza dei dipartimenti, mettere sotto sorveglianza le aree più “sensibili”, ridisegnare le assunzioni secondo criteri politici.
Alcune proposte sono inquietanti: limitare l'accesso di studenti stranieri, rivedere l’autonomia dei rettorati, ridurre la libertà dei docenti. Come se la libertà accademica fosse un ostacolo da rimuovere, non un valore da difendere.
Colpire le università significa anche colpire ciò che esse rappresentano: la diversità come motore di crescita. L’idea che gli atenei debbano “tornare americani” non è solo uno slogan: è un attacco alla natura stessa della ricerca.
Le istituzioni più avanzate non sono diventate tali chiudendosi, ma aprendosi. Accogliendo menti brillanti da ogni parte del mondo. Dalla fuga dei cervelli europei negli anni ’30, fino ai flussi attuali, la spinta all’innovazione nasce dall’incontro.
Ridurre questo scambio significa amputare il futuro.
Chi promuove l’omogeneità spesso dimentica che nella scienza, nella medicina, nella tecnologia, la ricchezza nasce dal confronto tra approcci, storie, punti di vista. Ogni barriera è un passo indietro.
Lo dicono le statistiche, ma soprattutto lo dimostra la storia: dai laboratori universitari sono nate le scoperte che hanno rivoluzionato il mondo. E quasi sempre, a guidarle, c’erano squadre miste, transnazionali, trasversali.
Chi ha paura della diversità ha paura del cambiamento. Chi invoca l'identità rischia di sacrificare la creatività sull'altare della chiusura.
Negare i visti, rendere più difficili le iscrizioni, mettere in discussione il diritto a studiare e fare ricerca: tutto questo allontana i talenti. E non solo quelli potenziali.
Chi è già negli Stati Uniti inizia a guardarsi intorno. Le università canadesi, europee, asiatiche accolgono con entusiasmo chi si sente respinto. E mentre l’America si ritrae, il mondo va avanti.
Il danno non è solo d’immagine. È strutturale. E rischia di trascinare nel fango decenni di primato culturale e scientifico.
Il nodo politico
Dietro questa crociata, c’è anche un calcolo elettorale. Colpire l’università significa parlare a una fetta di elettorato che si sente esclusa, trascurata. Significa fare leva sul risentimento verso chi è percepito come “élite”.
È una strategia nota: trasformare la cultura in campo di battaglia. Alimentare la frattura tra chi studia e chi lavora. Tra chi ha accesso e chi resta fuori. Ma è una frattura costruita ad arte, non naturale.
Le università non stanno a guardare. Harvard ha scelto la linea dura, ricorrendo ai tribunali. Altre si muovono con più cautela, cercando compromessi per salvare il salvabile. Ma tutte si trovano davanti a un bivio: piegarsi o resistere.
L’esito di questo scontro è ancora incerto. Ma una cosa è chiara: difendere l’università non è solo un atto accademico. È un gesto politico. E civile.
Non si tratta solo di scegliere da che parte stare. Si tratta di decidere quale futuro immaginare. Se vogliamo una società aperta, capace di generare idee, di confrontarsi, di affrontare le sfide con coraggio, le università devono restare spazi liberi.
Spazi dove la conoscenza non ha passaporto. Dove il pensiero non si piega al potere. Dove la ricerca non si misura solo in dollari, ma in impatto umano.